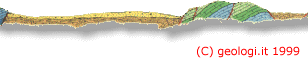|
0 membri (),
354
ospiti, e
8
robot. |
|
Chiave:
Admin,
Mod Globale,
Mod
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2021
Posts: 13
Junior Member
|
OP

Junior Member
Iscritto: Sep 2021
Posts: 13 |
Salve, mi rendo conto che non è un problema fondamentale ma penso/spero che possa interessare la comunità almeno a livello di curiosità. Si tratta dell'acqua di Marte. Ormai il problema non sembra più se ce ne può essere ma piuttosto quanta, dove e come. Vorrei segnalarvi questo studio, appena pubblicato, dove nella figura 10 sembra di osservare le tre fasi dell'acqua contemporaneamente sullo stesso versante (una duna) e nello stesso momento. https://www.mdpi.com/2076-3263/15/1/29Al di là della possibile spiegazione (un effetto aerodinamico) questa eventualità si evince facilmente dal diagramma di figura 13. Il problema della liquidità dell'acqua su Marte non è il freddo ma la pressione. Spesso non ci si rende conto che il punto triplo non fa parte del nostro ambiente ma è invece presente nell'ambiente marziano. E' per questo motivo che, soltanto su Marte, può bastare una variazione di qualche grado e/o di qualche millibar per attraversare tutte le fasi dell'acqua. Cercando in un sito le cui condizioni ricadano almeno stagionalmente in quel piccolo cuneo, si potrebbe trovare acqua anche liquida. In realtà questi fenomeni sono rari, stagionali e anche di brevissima durata, ma sono possibili. Inoltre - ed è forse la cosa più importante - qualunque fenomeno erosivo che sembra associato all'azione di un liquido non può essere associato alla CO2, che ha bisogno di oltre 5 Bar per liquiefare. Sottolineo questo per contrastare la vecchia scuola di fisici che storicamente hanno attribuivano fenomeni erosivi alla lava per poi ripiegare sulla CO2. Questo è uno studio che riguarda una particolare sottospecie di gullies ma fa seguito a un lavoro precedente sulla più diffusa e canonica tipologia "ACA". Mentre queste sono delle false sorgenti geologiche, i gullies ACA sarebbero delle vere sorgenti, la cui attività è comunque stagionale, transitoria ma soprattutto (qui la differenza con la Terra) strettamente legata alle variazioni di pressione e temperatura dell'ambiente esterno: https://doi.org/10.3301/IJG.2022.12 E' noto che ci sono stati tempi migliori, ma la tenue atmosfera rimasta sul pianeta potrebbe svolgere ancora un ruolo molto importante nell'influenzare i fenomeni superficiali, non solo attraverso il vento. Abbiamo anche elaborato un codice di datazione normalizzato al ciclo stagionale che spero possa essere utile a chi volesse cimentarsi nello studio dei fenomeni transitori marziani: Teoria: https://www.mdpi.com/2076-3263/14/4/108Algoritmi (Excel, Phyton, Mathlab): https://www.earth-prints.org/handle/2122/16819Spero che tutto questo possa incontrare l'interesse dei colleghi esperti nel (vero) settore dell'idrogeologia. Grazie dell'attenzione. Adriano
|
|
|
|
|
Iscritto: Jun 2015
Posts: 277 Mi piace: 3
Member
|

Member
Iscritto: Jun 2015
Posts: 277 Mi piace: 3 |
molto interessante; senz'altro sono forme attive. Ho guardato velocemente le figure. Una differenza che si nota subito tra quelli che chiamate ACA classici e i "vostri" dunali sembra essere l'assenza di depositi al piede dei secondi, o sbaglio?
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2021
Posts: 13
Junior Member
|
OP

Junior Member
Iscritto: Sep 2021
Posts: 13 |
Esatto, i gullies "lineari" non lasciano depositi al piede. In realtà c'è uno spostamento della sabbia, più che altro laterale a formare argini rialzati. Al termine del pendio la spinta di scivolamento può formare il "cucchiaio" in cui si fermano le "palle di ghiaccio". Invece gli "ACA", come hai visto, hanno una struttura "nicchia/canale/conoide" (acronimo ACA). Però osserva anche che i canali ACA non attraversano mai i loro conoidi, se non per poco e in rari casi. Piuttosto l'incisione si affievolisce fino a svanire proprio in corrispondenza dell'apice del deposito. E' perché l'acqua, che già era instabile alla sorgente, a quella quota più bassa è evaporata totalmente, depositando in modo secco il materiale trasportato. Per questo modello vedi il precedente lavoro sugli ACA ( IJG). Nota che non esiste a valle degli ACA un bacino di raccolta o un collettore delle acque, come troveresti da noi. Passeggiando in Patagonia (con Google Earth, ovviamente) ho trovato molte forme simili agli ACA ma con i conoidi incisi e, magari ghiacciati, anche dei laghetti di raccolta sul fondovalle. Purtroppo la pressione atmosferica di Marte non consente la stabilità della fase liquida.
|
|
|
|
|
Iscritto: Jun 2015
Posts: 277 Mi piace: 3
Member
|

Member
Iscritto: Jun 2015
Posts: 277 Mi piace: 3 |
mi chiedevo anche se, in qualche aspetto delle morfologie che avete indagato, sia rilevabile l'effetto di una gravità tutto sommato 2,5 volte inferiore a quella terrestre. E, a parte la gravità, avete preso in considerazione la possibilità di riprodurre in scala le condizioni che pensate siano all'origine delle forme e quindi confermare sperimentalmente il vostro modello?
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2021
Posts: 13
Junior Member
|
OP

Junior Member
Iscritto: Sep 2021
Posts: 13 |
Effetto della gravità. Sinceramente ero convinto che i depositi al piede dei canali ACA, che spesso dalle foto apparivano "troppo" ripidi, avessero un angolo di riposo maggiore di quello terrestre a causa della gravità più bassa. Con l'aiuto di colleghi fisici abbiamo riformulato l'espressione matematica di questo angolo e con mia sorpresa l'accelerazione di gravità non influisce. Naturalmente la gravità è fondamentale, ma il valore di g non cambia l'angolo. Come sulla Terra dipende dalle caratteristiche dei clasti. Probabilmente la ripidità è a volte falsata dalla prospettiva della visione aerea o dall'elaborazione delle ortofoto. Simulazione in laboratorio. Ci penso spesso ma è meno facile di quanto sembra (questione anche di costi e di spazi). Occorre riprodurre e poter mantenere costanti non solo temperatura e pressione ma anche la composizione chimica dell'atmosfera. Ci sono stati esperimenti che hanno già provato quello che immaginavo, cioè che l'acqua instabile (bollente a bassa temperatura: diciamo "effervescente naturale"  ) anche se per un breve tratto, può produrre maggiore erosione rispetto all'acqua... "liscia" 
|
|
|
|
|
Iscritto: Jun 2015
Posts: 277 Mi piace: 3
Member
|

Member
Iscritto: Jun 2015
Posts: 277 Mi piace: 3 |
Effetto della gravità.
Sinceramente ero convinto che i depositi al piede dei canali ACA, che spesso dalle foto apparivano "troppo" ripidi, avessero un angolo di riposo maggiore di quello terrestre a causa della gravità più bassa. Con l'aiuto di colleghi fisici abbiamo riformulato l'espressione matematica di questo angolo e con mia sorpresa l'accelerazione di gravità non influisce. Naturalmente la gravità è fondamentale, ma il valore di g non cambia l'angolo. Come sulla Terra dipende dalle caratteristiche dei clasti. Probabilmente la ripidità è a volte falsata dalla prospettiva della visione aerea o dall'elaborazione delle ortofoto.
) La questione è interessante. Sembrerebbe in effetti controintuitivo, ma l’angolo di “natural declivio” o di riposo per un sedimento sciolto privo di coesione, corrispondente all’angolo di attrito interno, dovrebbe non dipendere dal valore di g; è cosi? E’ lo stesso motivo per cui l’angolo di riposo non dovrebbe mutare per un sedimento sciolto in condizioni di sommersione rispetto allo stato asciutto, intervenendo in quel caso l’alleggerimento per la sottospinta idrostatica, il che equivarrebbe ad una diminuzione di g. Ma in condizioni dinamiche, quando è stato superato lo stato limite ultimo (il sedimento o la “palla di ghiaccio” ha iniziato a scivolare lungo il pendio), le cose dovrebbero cambiare e le forme dovrebbero di conseguenza assumere configurazioni diverse; ad esempio, l’entità dell’incisione di un canalone, la lunghezza di questo, la velocità con cui le “palle di ghiaccio” scivolano lungo il pendio, la distanza percorsa… Certo che l'acqua "in ebollizione" lungo un versante dovrebbe avere una capacità erosiva maggiore, essendo il flusso ancora pi turbolento per la liberazione di bolle di vapore in tutto il volume che scorre; mi viene in mente un'analogia con il magma in degassazione quando si approssima alla superficie per diminuzione della pressione che induce la liberazione dei gas. Pensavate a una galleria del vento?
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2009
Posts: 1,008 Mi piace: 1
Member
|

Member
Iscritto: Dec 2009
Posts: 1,008 Mi piace: 1 |
Solo per dirvi che seguo con interesse
La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia,
ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2021
Posts: 13
Junior Member
|
OP

Junior Member
Iscritto: Sep 2021
Posts: 13 |
Visto che c'era stato interesse per l'acqua segnalo anche questo lavoro appena pubblicato: Remote Sensing: Geomorphological Evidence of Ice Activity on Mars Surface at Mid-Latitudes. Sembra trattarsi di ghiaccio di superficie ma a medie latitudini (più o meno quella di Lampedusa  ). Una specie di lingua glaciale ma priva del ghiacciaio vero e proprio. Del resto non può esistere oggi una zona di accumulo di precipitazioni nevose in quanto non può proprio nevicare. Tuttavia a una certa profondità si può avere una parziale fusione del permafrost e il ghiaccio sembra provenire proprio dalle pendici della valle, modellandole. Si vedono delle nicchie che a prima vista sembrano formare meandri, perché le vediamo sfasate, ma è altrettanto evidente che si hanno spesso due concavità opposte. Ci sono molte strutture di questo tipo nella stessa zona. L'Ariguani Delta System è così chiamato perché si riteneva un delta di Gilbert (dell'epoca in cui pioveva, 3.7 miliardi di anni fa). Non escluderei un'origine diversa da quella glaciale, anche se... manca un fiume vero e proprio. Forse fu più una tracimazione del lago che si sarebbe formato, in ambiente pluviale, nel cratere da impatto di Ariguani. (Ci sono altri esempi di argini sfondati in molti altri crateri della zona). Oggi però sembra essersi impostata una particolare dinamica del ghiaccio che sembra compatibile con l'ambiente attuale locale. In questo lavoro vengono evidenziati in tutta l'area dei pattern morfologici che caratterizzano questo particolare ambiente e la cui presenza in associazione potrà rivelare l'attività di ghiaccio superficiale anche in altre aree di Marte.
|
|
|
|
|
Iscritto: Jun 2015
Posts: 277 Mi piace: 3
Member
|

Member
Iscritto: Jun 2015
Posts: 277 Mi piace: 3 |
Senz’altro interessante, grazie; lo leggerò con calma quando avrò un po’ di tempo. Di primo acchito, ma solo in maniera del tutto superficiale, mi vengono in mente i rock glaciers terrestri
|
|
|
|
|
Iscritto: Jun 2015
Posts: 277 Mi piace: 3
Member
|

Member
Iscritto: Jun 2015
Posts: 277 Mi piace: 3 |
Ho letto una parte del lavoro; non so se viene spiegato altrove o in lavori precedenti, ma mi riesce difficile immaginare (e non ho gli strumenti per osservarli dagli ingrandimenti riportati nelle immagini) i cosiddetti "Poliedri a spigoli vivi" e quale sia il loro meccanismo di formazione. Gli "spigoli vivi" mi richiamano quelli di una superficie ghiacciata a scallops, è qualcosa di simile?
|
|
|
Link Copiato negli Appunti
|
Forum36
Discussioni21,024
Post147,694
Membri18,094
| |
Massimo Online2,054
Oct 21st, 2025
|
|
|
|